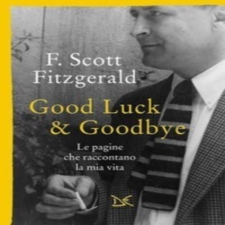Ci sono momenti bellissimi in questo Good Luck & Goodbye – Le pagine che raccontano la mia vita (Donzelli) di Francis Scott Fitzgerald: non proprio un’autobiografia quanto una raccolta di “scritti personali”, apparsi su giornali e riviste che il creatore del Grande Gatsby avrebbe voluto fortemente riunire in un libro senza peraltro riuscirvi.
Ci sono momenti bellissimi in questo Good Luck & Goodbye – Le pagine che raccontano la mia vita (Donzelli) di Francis Scott Fitzgerald: non proprio un’autobiografia quanto una raccolta di “scritti personali”, apparsi su giornali e riviste che il creatore del Grande Gatsby avrebbe voluto fortemente riunire in un libro senza peraltro riuscirvi.
Com’è noto, quella di Fitzgerald – se ben tradotta – è una prosa di straordinaria tensione musicale. L’equilibrio con cui lo scrittore americano tiene insieme tonalità differenti è raro. Gli riesce – lo sappiamo – di essere poetico persino parlando di denaro, argomento che gli stava molto a cuore (alcuni di questi scritti lo confermano). Se in un libro del genere non ti aspetti l’arte (considerando che a Fitzgerald succedeva persino con i racconti di evitare l’ingombro di eccessive riscritture, per guadagnare più in fretta) resti invece folgorato dalla brillantezza stilistica cristallina che qui è la misura dello scarto letterario dall’ovvio: lo slittamento imprescindibile che rende sorprendente e vivo il più trito degli argomenti.
Così, appare limitante il ricorso a schemi sociologici che interpretino quella di Fitzgerald come una voce della cosiddetta età del jazz, come una modulazione fra altre nel passaggio dai soldi facili del decennio successivo alla Grande Guerra al fatidico 1929. Non che il trauma non lo riguardi o che egli non sappia sintetizzarne la cifra, ma lo humor derisorio intriso di malinconico disincanto con cui descrive tutto ciò è suo e di nessun altro.
Un’(auto)ironia che peraltro anticipa di anni il crollo di Wall Street. Dopo i primi guadagni successivi al romanzo Di qua dal Paradiso, passano tre mesi e il nostro scopre “con orrore” di non avere un soldo. Anche lui è costretto a fare i conti con “il budget”. Con Zelda si industria a stilare “svariati libri contabili”. Si domanda “se comprare il giornale della domenica una volta al mese o fare l’abbonamento a un almanacco”. Se si deprime lo fa con ilare giudizio. Poi decide di andarsene a svernare con la celebre moglie nel sud della Francia dove impara “come vivere con praticamente con niente”.
“Andavamo nel Vecchio mondo alla ricerca di un ritmo nuovo per le nostre vite, con la sincera convinzione di esserci lasciati per sempre alle spalle quello che eravamo prima – e con un capitale poco oltre i settemila dollari”. Non sarà così, naturalmente. Tornerà in America (New York appare un superbo palcoscenico di alcolizzati di genio e non) e riprenderà la sua vita dispendiosa. Vorrei dire però che tutto questo alla fin fine è secondario. E anche l’eccentricità del personaggio, che arriva al dunque come il tiratore con l’arco addestrato allo zen: “Il particolare tipo di povero scemo che ho in mente non deve mai scordare che più lo chiamano povero scemo e meno lo è. Quello che conta è essere un povero scemo diverso dagli altri”.
Di che cosa parla? Di chi “crede fortemente in qualcosa e persegue solo quella cosa”. Nel suo caso, la scrittura. Richiamarne la biografia come traccia di un’epoca insomma ha poco senso. L’uomo che consiste in “tre metri quadrati di pelle vulnerabile alle febbri e ai brividi” e che quando mette su famiglia scopre che ne occupa sei (e che quella, già a 25 anni, è la mezza età), che si sfinisce di feste e di cocktail, che suscita invidie anche postume per uno stile di vita leggendario, che però è costretto a fare i conti anche emotivi con un mondo che ben presto smette di essere “una faccenda privata, in cui bisognava solo bilanciare il senso della futilità dello sforzo con quello della necessità della lotta”, be’ quest’uomo fa pensare in realtà a un involontario maestro che, smaliziato come pochi, potrebbe suggerire paradossali, inattese pillole di buona salute – specie alla odierna malmostosa invasione di pedagogisti, psicologi, tromboni di ogni risma, anche in salsa letteraria. Solo che lo farebbe senza parere – persino senza volerlo. Si veda lo scritto “Aspetta di avere figli!”. “Non voglio – scrive – che la mente di mio figlio venga stimolata da qualsiasi ciarlatano (…), gli dirò che sul senso della vita in questo mondo io ne so davvero poco più di lui (…), voglio che i miei figli si sentano soli (…), che sappiano la verità: che sono sperduti in un mondo strano al confronto del quale il mistero di tutte le caverne e di tutte le foreste non è niente”. E che “nulla di quanto gli verrà detto avrà più valore di quello che mio figlio scoprirà per conto suo”.
Ora, in questi anni di poltiglia psicologistica, di iperprotezione demenziale degli imberbi, di infantilismo protratto ai trent’anni, di mamme che adorano – loro – Peppa Pig e ignorano le fiabe che ci preparano alla crudeltà del vivere, ditemi voi se questo è un uomo frivolo.
Al materiale previsto dallo scrittore americano nel progetto del 1936, Donzelli ha aggiunto altri scritti successivi a quella data. Il denso glossario finale aiuta a districarsi fra i vari nomi, luoghi, argomenti. Un libro meritorio e ben tradotto da Maurizio Bartocci, tutto da godere, col solo difetto di qualche refuso di troppo.
Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) è stato uno degli scrittori americani più popolari della Lost Generation. Conquistata la notorietà col romanzo Di qua dal Paradiso (1920), cominciò a condurre una vita leggendaria e dispendiosa tra New York e l’Europa, insieme ad altri talenti dell’epoca e alla moglie Zelda, con la quale formò la coppia più celebre dell’Età del jazz. Nel 1922 pubblicò il secondo romanzo, Belli e dannati, e nel 1925 il suo capolavoro, Il grande Gatsby. Negli anni trenta, in coincidenza con la malattia mentale di Zelda, iniziò per lo scrittore un inesorabile declino. Il suo romanzo Tenera è la notte fu un insuccesso; ormai preda dell’alcol, Fitzgerald morì nel 1940.
Autore: F. Scott Fitzgerald
Titolo: Good Luck & Goodbye. Le pagine che raccontano la mia vita
Editore: Donzelli
Traduzione: Maurizio Bertocci
Anno di pubblicazione: 2013
Pagine: 364
Prezzo: 23 euro